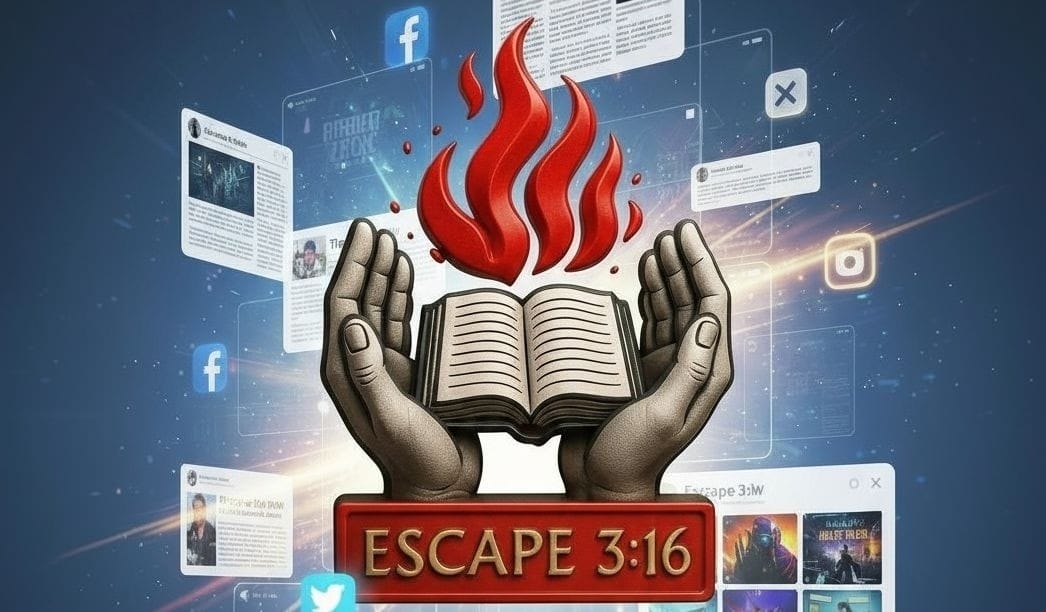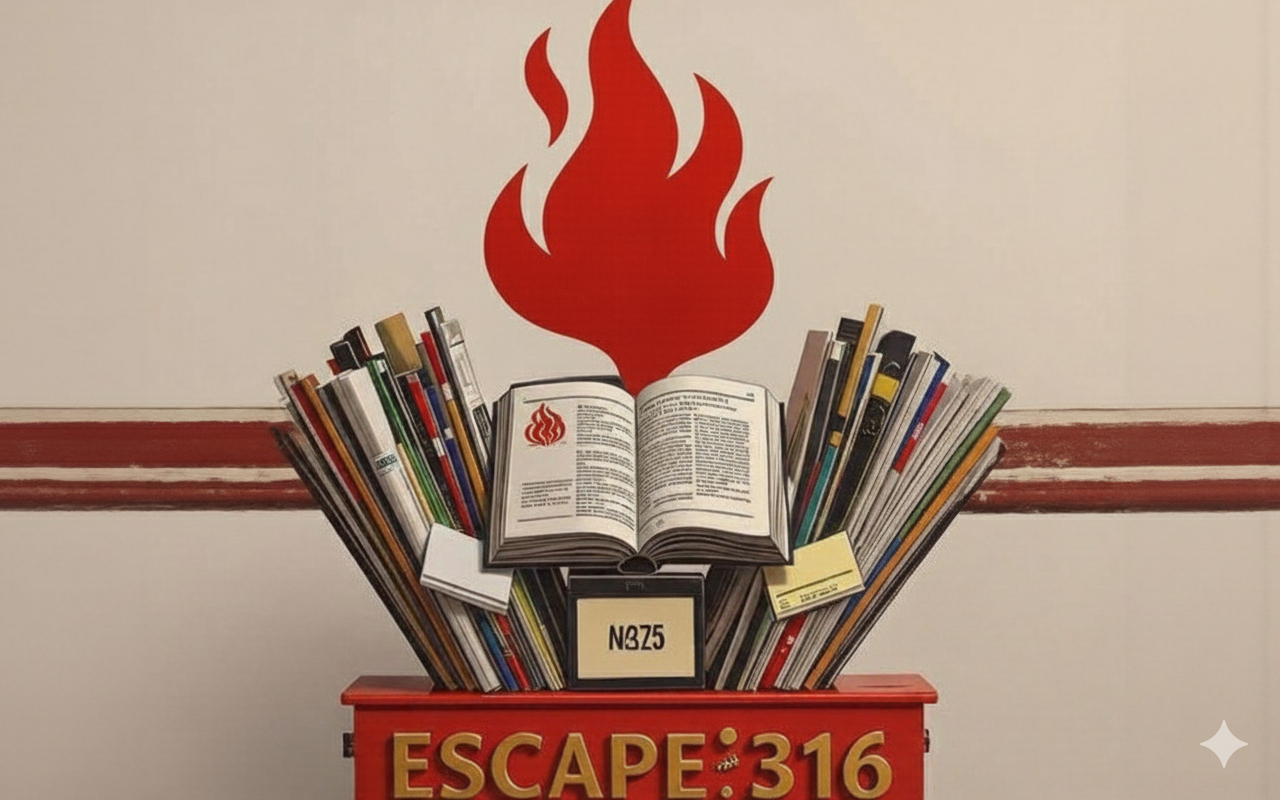Roma (NEV), 28 ottobre 2025 – Intervista a Gianfranco Macrì, professore ordinario di Diritto interculturale e delle religioni e Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione – Università degli Studi di Salerno a margine del Seminario di studi in occasione del 70° anniversario dell’abrogazione della circolare Buffarini-Guidi (1935-1955) “Liberi e dis-eguali: la libertà religiosa in Italia a partire dal caso pentecostale”. Il Seminario si è tenuto lo scorso 21 ottobre presso l’Università di Salerno ed è promosso, fra l’altro, dalla Facoltà pentecostale di scienze religiose.
Locandina Seminario Buffarini-Guidi def.
Professor Macrì, qual è il messaggio principale che questo convegno ha portato oggi, a settant’anni dall’abrogazione della circolare Buffarini-Guidi?
Il convegno del 22 ottobre scorso ha voluto riportare all’attenzione di studenti e ospiti presenti due aspetti inerenti al tema della libertà religiosa in Italia, sotto il profilo storico e giuridico; dunque: quanto male ha cagionato sulla pelle dei pentecostali – e di riflesso sulle sorti del variegato panorama protestante italiano – l’adozione di quello strumento a cavallo tra la fase più aggressiva della dittatura fascista e la prima età repubblicana; ma pure quanto è costato, in termini innanzitutto culturali, oltre che politici e normativi, l’attuazione di un progetto costituzionale di libertà religiosa capace di garantire a tutti (persone e organizzazioni) il “diritto di professare liberamente la propria fede religiosa” (art. 19 Cost.). Le testimonianze di alcuni rappresentanti di chiese protestanti, i contributi di studiosi (storici e giuristi) e alti funzionari dello Stato, le domande degli studenti, hanno stimolato il dibattito e fatto emergere profili della vicenda pentecostale sconosciuti, specie ai più giovani.
A che punto siamo oggi in Italia sulla tutela delle minoranze religiose? Le garanzie sono effettive o ci sono ancora ombre e ritardi?
Premetto che trovo il termine “minoranze” non adeguato dal punto di vista del modo in cui la Costituzione si rapporta al fattore religioso organizzato. L’art. 8, comma 1 Cost., infatti, dice che “tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge”. Questo significa che in uno Stato laico e pluralista il criterio numerico non può giustificare disparità di trattamento tra organizzazioni religiose, né alcun potere di apprezzamento sui contenuti delle diverse credenze o sulle modalità di espressione di ogni singolo culto. Detto questo, la storia repubblicana è costellata di numerosi fatti che testimoniano la difficoltà di dare attuazione “pratica” alla norma citata. La libertà religiosa è in affanno (non solo in Italia, purtroppo) per la cattiva volontà della politica di mettere al centro del dibattito parlamentare la “questione religiosa” per come merita, vista la sua rinnovata complessità. Non è pensabile, allo stesso tempo, “scaricare” questa responsabilità in capo alla giurisdizione. Occorre dare avvio ad una nuova stagione di confronto e di partecipazione, senza lasciare ai margini nessuno.
In che modo le chiese pentecostali possono fungere da “cartina tornasole” contro le discriminazioni (sia quelle palesi, sia quelle sottili) e contribuire a monitorare il rispetto dei diritti?
L’esperienza pentecostale è certamente molto significativa perché la storia di questa comunità religiosa è oramai ben nota e questo la rende idonea a fungere, appunto, da “cartina di tornasole” per comprendere il percorso in salita della libertà religiosa nel nostro paese. Raccontarla è utile, come tutte le vicende drammatiche ruotanti attorno a persone e gruppi di fede che hanno segnato la vita del paese – non solo nella fase buia del Fascismo. Oggi, nuove realtà religiose si affacciano (o tornano ad affacciarsi: l’Islam per esempio) all’interno del panorama pubblico italiano. Questa rinnovata complessità culturale pone domande specifiche alle istituzioni e richiede ulteriore lavoro e approfondimento. Occorre capire che la libertà religiosa è un diritto fondamentale che viaggia “a braccetto” con altri diritti, innanzitutto sociali. Se questi ultimi vengono ridimensionati o finanche negati, a “reagire” (difensivamente) sarà inevitabilmente il mondo come la singola persona oppure la specifica comunità si troverà a vivere quel particolare disagio, dando vita a comportamenti anche problematici che possono mettere in moto, di riflesso, istanze di tipo securitario o repressivo.
Quanto pesano ancora gli stereotipi e l’ignoranza religiosa nel generare diffidenza verso le minoranze?
Stereotipi e ignoranza possono “pesare” diversamente a seconda dei contesti. Nelle periferie del mondo (che non significa per forza i quartieri più lontani dal centro di una città) le “minoranze” possono costituire un problema, ma pure offrire una opportunità. Tutto sta nel capire quanto la società, nelle diverse articolazioni “orizzontali”, e gli apparati pubblici sono disposti a collaborare “insieme” per dare vita ad una cittadinanza inclusiva, che investe nel dialogo (interculturale e interreligioso) e nella partecipazione. Se questo accade – e gli esempi positivi sono tanti – la speranza di non soccombere ai nazionalismi può essere una meta raggiungibile.
Qual è, secondo lei, la priorità più urgente per migliorare le politiche sulla libertà religiosa nei prossimi anni? Da dove bisogna partire: scuola, istituzioni, comunicazione, riforme legislative…?
Le politiche in materia di libertà religiosa sono panieri da riempire con azioni continuative che partono dal monitoraggio dei fatti reali e arrivano a proporre soluzioni non solo di matrice legislativa. Le buone prassi, prima ancora della norma giuridica, servono a predisporre il terreno, perché hanno la forza di non escludere nessuno: tutti sono chiamati a contribuire. Si tratta, perciò, di imbastire una trama aggiornata del principio solidaristico e della democrazia pluralista come perimetro generale. L’adesione a questi capisaldi serve a stabilire che la nuova cittadinanza si costruisce aggiungendo e non escludendo gli “altri”. Solo a questo punto il diritto farà la sua comparsa. Personalmente auspico l’adozione di una legge generale sulla libertà religiosa che funga da terreno comune a tutte le istanze di accreditamento giuridico del fenomeno religioso collettivo, e di un recupero dello strumento delle intese (art. 8, comma 3 Cost.) quale vettore per salvaguardare le specifiche identità di ogni singolo gruppo.
Vai all'articolo su Nev