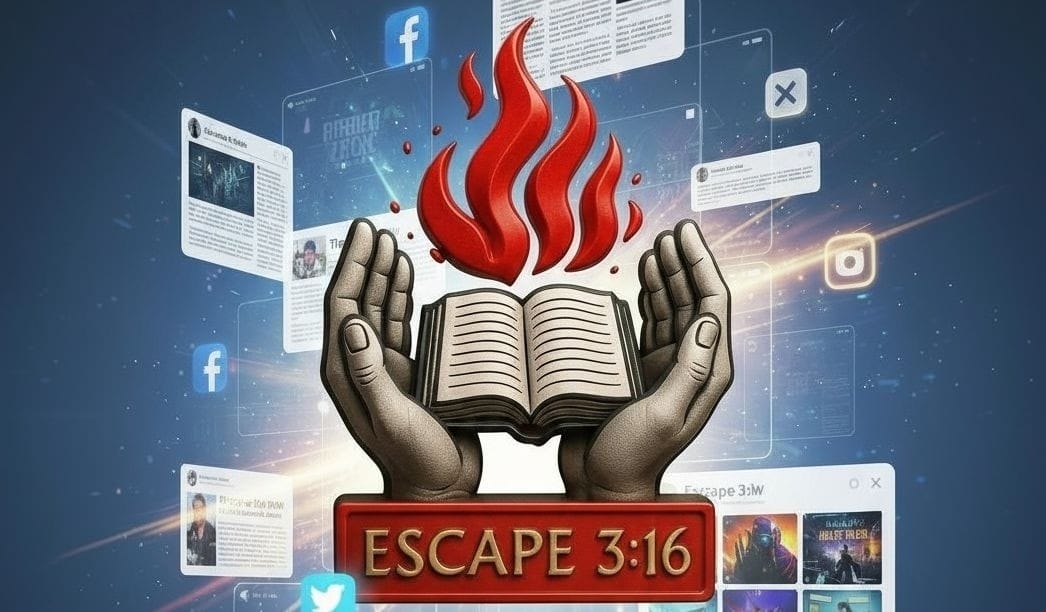Roma (NEV), 22 ottobre 2025 – Si è conclusa da poco l’edizione di Torino Spiritualità 2025. Consolidato appuntamento culturale, vede da sempre il contributo del mondo protestante. Anche quest’anno la città ha aperto i suoi spazi ai grandi interrogativi del vivere contemporaneo, tra cui quello sul vuoto, sul tempo e sulla ricerca di senso. In questo orizzonte si collocano due momenti che hanno portato una voce evangelica nei giorni del festival: l’incontro del Comitato Interfedi, dal titolo “Vuoti e pieni nel cammino alla ricerca di senso” il 16 ottobre presso il Circolo dei lettori con la pastora Elisabetta Ribet, e il dialogo “Il tempo fertile dell’attesa”, che si è svolto il 18 ottobre al Museo Nazionale del Risorgimento con Cristina Arcidiacono, pastora battista, e lo scrittore Fabio Geda, moderati dal curatore del festival Armando Buonaiuto.
«Il vuoto come spazio che attende» – la riflessione di Arcidiacono
Arcidiacono racconta di come, nel dialogo con Geda, il tema del vuoto sia stato affrontato a partire dal tempo dell’attesa: un tempo che nella Bibbia non è mai passivo. «La fede cristiana si regge su un paradosso: chi vorrà salvare la propria vita la perderà; ma chi la perderà per causa mia la troverà», ha spiegato. «Per Paolo, perdersi e salvarsi, vita e morte, sono dinamiche intrecciate: morire a se stessi per vivere in Cristo. È un movimento che interpella la nostra idea di pienezza».
Da qui il legame tra vuoto e tempo: «Questo paradosso si regge su Gesù stesso: l’inno ai Filippesi racconta che, pur essendo in forma di Dio, si svuotò per amore dell’umano, entrando nella storia. Il vuoto, allora, ha a che fare con il tempo e con il modo in cui lo abitiamo».
Arcidiacono richiama le parabole evangeliche della vigilanza: «Le Scritture parlano spesso di un’attesa vigile: vegliate, perché non sapete né il giorno né l’ora. C’è uno stare prima ancora che un fare. Come il seme che cresce da solo, nel silenzio della terra: il vuoto non è un deserto sterile, ma uno spazio che può generare».
L’incontro – sottolinea – è stato prezioso anche per la sintonia emersa con il racconto di Geda sul suo viaggio in Angola per Medici con l’Africa CUAMM, e sul suo lavoro narrativo attorno all’attesa, intesa come perseveranza (hypomoné), tema caro sia alla tradizione biblica sia a pensatrici come Simone Weil. «Abitare il vuoto come attesa – ha aggiunto Arcidiacono – significa riconoscere che non tutto dipende da noi, e che il tempo può essere grembo e non solo calendario».
La casa dell’attesa – Fabio Geda
«Il vuoto può ferire, ma può anche generare»
In questo altro dialogo curato dal Comitato Interfedi, la voce protestante di Elisabetta Ribet ha proposto una riflessione che ha fatto da contrappunto ideale. Sul rapporto tra tempo, senso e ricerca spirituale ha domandato:
«Ogni persona abita il tempo e si adopera per dare senso alla propria esistenza: ma in che modo riempiamo i nostri giorni? Quella risorsa non rinnovabile che scandisce le nostre vite è davvero buona soltanto quando è in qualche modo “piena”?»
E ancora: «Se la sfida, oggi, fosse invece quella di liberare, di fare spazio affinché Qualcosa d’Altro possa essere accolto?»
Da qui il percorso biblico: «La creazione è risposta di Dio al vuoto primordiale. La Parola creatrice abita e plasma il “vuoto”.» «“Non è qui”: le parole con cui i vangeli sinottici danno il primo annuncio della resurrezione.» «Gesù si è spogliato della sua potenza divina, e lo ha fatto per amore dell’umano. Uno spogliarsi che interpella il nostro modo di “svuotarci”.»
Ribet ha ricordato anche il vuoto come ferita: «Il vuoto che strappa, lacera, ferisce e annienta nasce quando la fraternità è rifiutata, quando la sororità è disprezzata, quando l’altro-più-vicino non è riconosciuto.» e la definizione conseguente: «Una prima definizione di “vuoto”, per la fede cristiana, è assenza di relazione. Non c’è umanità se non c’è relazione.» Quale consolazione, allora, quale rassicurazione, davanti all’inesorabile fragilità dell’umano? Si chiede Elisabetta Ribet. «La certezza che siamo amati. Che sono amata, che lo sei. Anche quando sono ferma immobile, quasi inerte. Anche quando non “produco” e non presenzio. Anche quando non ho qualcosa da dire e la stanza è abitata dal silenzio. Che lascia spazio alla presenza, alla consapevolezza che il vuoto è necessario, perché lo Spirito possa circolare, perché i legami possano vivere ed essere nutriti e tessuti.»
Il vuoto, ha aggiunto, è anche promessa: «La tomba vuota, immagine di una resurrezione non vista, è la breccia della speranza… Il vuoto non è solo perdita: è – può essere – possibilità di esistenza, lo spazio che si cerca per ciò che è possibile.»
Tra spaesamento e libertà
E che il vuoto sia lo spazio del possibile è lo spunto da cui questa XXI edizione di Torino Spiritualità ha preso le mosse: «Negli ultimi anni abbiamo scelto di imperniare la riflessione del festival su alcune circostanze in cui chiarore e tenebra sono densamente fusi insieme», spiega Armando Buonaiuto, curatore della manifestazione. «Così è stato nel 2023, quando abbiamo ragionato sul tema della morte, e nel 2024, quando abbiamo messo sotto osservazione la dimensione dell’errore. Quest’anno, però, abbiamo provato a indagare la tensione tra scintilla di luce e abisso d’ombra esplorandone la forma più pura e cangiante, che a mio parere è appunto quella del vuoto. Impalpabile e pervasivo, davvero il vuoto riempie le nostre vite, e lo fa in tante forme: può essere la voragine in cui smarrirsi, ma anche la sorgente da cui sgorga ogni divenire possibile. È spaesamento ed è vertigine, ma è anche emancipazione, libertà, potenza dinamica, cosa viva… Nel Taoismo si dice che non siano i raggi, bensì il vuoto del mozzo a far girare la ruota. Ossia: l’efficacia che dà compimento alle cose è proprio lì, nel vuoto, dove meno ci aspetteremmo di trovarla. E d’altronde, non è nella sottrazione che si compie ogni vero cammino spirituale?»
Vai all'articolo su Nev